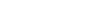AVRESTE MAI IMMAGINATO L'ESISTENZA DI UNO STALINISMO ESTETICO? *
AVRESTE MAI IMMAGINATO L'ESISTENZA DI UNO STALINISMO ESTETICO? *
di Antonello Colimberti
http://www.ilcovile.it/scritti/COVILE_889_Antonello_Colimberti.pdf
«Il minimalismo è una sorta di fascismo, un’inutile costrizione di riduzione a forme deprivate di significato da un punto di vista tecnico e storico. È semplicemente un crimine intellettuale.»
Di chi sono tale parole, di una violenza abbastanza inconsueta nel mondo delle arti contemporanee, dove piuttosto a tutto, ma proprio a tutto, si trovano ragioni e significati? Sono parole pronunciate anni fa da Luciano Berio (1925–2003), uno dei piú celebrati compositori detti «d’avanguardia» della seconda metà del Novecento.
Ebbene, se la detta affermazione avesse un sia pur lontano contenuto di verità, dovremmo concluderne che il nostro Paese è davvero in pericolo. Vediamo perché.
Innanzitutto, cos’è il minimalismo musicale (perché di ciò in particolare si tratta)? Con questo termine si definisce un movimento e stile musicale sorto negli Stati Uniti poco piú di un cinquantennio fa. La data canonica è quella del 1964, anno in cui il quasi trentenne musicista californiano Terry Riley fece ascoltare una sua nuova opera, intitolata In C, che, tradotta nella nostra notazione musicale, significa In Do. Sí, proprio la nota do, il cui accordo in maggiore ostinatamente ripetuto segnava l’inizio del pezzo, che si avvaleva in tutto di 53 battute musicali da ripetere indefinitamente.
Malgrado si utilizzassero modalità dette «aperte» o «aleatorie», consuete nella musica d’avanguardia dell’epoca, era davvero troppo! Si pensi a quel che un pianista di vaglia come Glenn Gould (1932– 1982) scrisse dopo l’ascolto: «lo definirei prima di tutto un brano da ridere […] monotono monocromatismo». In realtà, era il segnale che il percorso musicale da Schönberg a Boulez non era obbligatorio, e che addirittura alla cosiddetta emancipazione della dissonanza si poteva opporre l’emancipazione della consonanza, e ad una complessità fondata sulla variazione continua si poteva opporre una semplicità fondata sull’ostinata variazione.
Accanto a Riley già operava da alcuni anni il coetaneo La Monte Young, che, dopo un iniziale periodo di partecipazione al celebre movimento della neoavanguardia chiamato Fluxus, stava maturando un progetto di drone music (musica fondata sulla ripetizione per lunghe durate di suoni o insiemi di suoni come bordoni) cui resterà fedele pertutta la vita. Poco tempo prima dell’esecuzione di In C La Monte, insieme con la moglie, l’artista visiva Marian Zazeela, aveva fondato il Theatre of Eternal Music, gruppo e progetto di un ambiente spazio-temporale dove suono e luce si materializzavano e si fondevano in un solo elemento: la musica.
All’abbrivio californiano di Riley e La Monte Young presto si unirà il versante newyorkese dei coetanei Steve Reich e Philip Glass, con i quali si definirà una volta per tutte il cosiddetto "minimalismo storico". Per la verità, agli inizi, per questo nuovo tipo di musica, si adoperavano varie denominazioni, fra le quali trance music o musica ripetitiva, ognuna amplificante un aspetto particolare. L’espressione che prevalse (minimal music, appunto) pare sia da attribuirsi ad un giovane critico inglese dell’epoca, che si chiamava… Michael Nyman!
Sí, proprio lui, uno dei piú famosi compositori viventi, all’epoca non componeva ancora, ma fu tra i primi a capire l’importanza della novità sonora che proveniva dagli Stati Uniti, fino al punto di pubblicare nel 1974 un aureo volume intitolato Experimental Music, in cui presentava la musica minimale come niente di meno che l’apogeo di una linea musicale che, inaugurata da Cage e dal precursore Satie, metteva ampiamente e radicalmente in questione le fondamenta stesse delle correlate idee di avanguardia ed evoluzionismo musicale.
Non è questa la sede per ripercorrere la diffusione europea e mondiale del fenomeno in questione, ma accenneremo invero a quella italiana, che tanto preoccupava Berio e non solo (non a caso il testo di Nyman è stato tradotto nel nostro Paese solo nel 2011 da una piccola, ma benemerita casa editrice della controcultura, la milanese Shake). Se le sedi deputate dell’alta cultura (teatri, sale da concerto, ecc.) stesero un cordone sanitario intorno alla inclassificabile nuova musica, un intelligente e coraggioso gallerista, Fabio Sargentini, che dirigeva la galleria L’Attico di Roma, a partire dal 1969 e per vari anni a seguire, invitò non solo gli esponenti storici del minimalismo, ma anche altre figure di primo piano come Charlemagne Palestine, a presentare le varie e capitali opere man mano composte; ultima, ma non per importanza, fu nel 1974 l’esecuzione integrale da parte di La Monte Young di The Well Tuned Piano, la sua opus magnum per pianoforte con accordatura microtonale, della durata di oltre cinque ore.
L’indefesso impegno di Sargentini spianò la strada ad un interessamento nelle alte sfere; cosí, grazie anche all’interessamento dell’allora giovanissimo compositore veneziano Claudio Ambrosini, nel 1976 la Biennale di Venezia si interessò a Terry Riley, Steve Reich e soprattutto Philip Glass, di cui fu rappresentata quell’opera geniale, realizzata con il regista Bob Wilson, che lasciò un segnò indelebile nella storia della musica del Novecento, e del teatro musicale in particolare: Einstein on the beach.
Dopo questa ufficiale emersione il cordone sanitario tornò. L’anatema di Berio e sodali funzionò, al punto che quando, nel 1984, fu presentata a Roma una nuova opera del duo Glass-Wilson, ossia The Civil Wars, il musicologo difensore della neoavanguardia, Mario Bortolotto (autore nel 1969 del testo ufficiale, evoluzionistico già nel titolo ripreso da Gottfried Benn, Fase seconda. Studi sulla Nuova Musica) sentenziò che si trattava di un «flusso sonnacchioso» e di un «fenomeno regressivo», al pari del Preludio dell’Oro del Reno di Wagner, del Bolero di Ravel e delle tragedie greche di Orff (sic!).
Non ci si stupisca: lo stesso celebratissimo musicologo qualche anno prima aveva definito Erik Satie non solo compositore insignificante, ma un musicista che non ha le carte in regola […] (autore) di piccoli compitini, da ricondurre alla sfera della socialità, della vita culturale francese, ma certamente escluderlo come capitolo, sia pure infimo, della storia della musica.
Satie e Glass, Berio e Bortolotto: tutto si tiene, anche nel linguaggio intimidatorio usato.
Fortunatamente il nostro Paese è anche ricco di personaggi indipendenti e coraggiosi, e cosí il minimalismo e il successivo post-minimimalismo hanno comunque trovato vie alternative per farsi conoscere. Tra di esse ci piace ricordare la splendida rassegna 4 pianoforti, ideata e curata ancora una volta da Fabio Sargentini insieme con Gianni Antognozzi e Paolo Coteni, che presentò a Palazzo delle Esposizioni, insieme a Riley, Glass e Palestine, il piú giovane Michael Harrison, nuova promessa del pianismo microtonale, ovvero della cosiddetta just intonation.
Ma è ancora una volta la Biennale di Venezia a sorprendere le aspettative conferendo lo scorso anno il Leone d’oro alla carriera a Steve Reich, il quale, intervistato subito dopo, cosa va a dichiarare? L’estetica dodecafonica era come il muro di Berlino […] la mia generazione ha detto basta […] noi non abbiamo fatto una rivoluzione, noi abbiamo fatto una restaurazione della normalità. Restaurazione della normalità? Se si pensa che Berio, in un’intervista del 1981, aveva definito Reich, di cui era stato a suo tempo insegnante in California, «autore di gags vagamente incantatori (ottenuti) sincronizzando e ripetendo con cocciutaggine squallidi patterns sonori che a poco a poco si sfasano», il riconoscimento e le parole decisamente politically incorrect, oltre che musically incorrect (gli increduli possono controllare su youtube), del suo allievo lo avrebbero confermato certo sui pericoli corsi nel nostro Paese. Pericoli che questi ultimi mesi dovrebbero aver portato allo stato d’allarme.
Senza scomodare il crescente successo internazionale di Ludovico Einaudi, compositore di derivazione post-minimalista, che sta presentando l’ultimo album Elements, si pensi all’Expo di Milano appena chiuso, dove ha fatto bella mostra, anzi audizione di sé, la musica di Roberto Cacciapaglia, altro compositore di derivazione postminimalista, usata come base musicale degli spettacoli di luce e acqua realizzati presso l’Albero della Vita. Ma si pensi anche agli ormai non meno noti Giovanni Sollima, non solo eccellente violoncellista, ma compositore di vaglia, anche lui coinvolto nell’Expo 2015 con il brano Terra di Variazioni, da cui è stato estratto l’inno della manifestazione, e Arturo Stalteri, pianista, critico e conduttore radiofonico, che ha presentato all’ultimo Festivaletteratura di Mantova «una storia parallela della musica del Novecento», quella del minimalismo appunto.
Potremmo andare avanti con tanti altri esempi, come la presentazione al Teatro dell’Opera di Roma del’accattivante I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky di John Adams, uno dei compositori attualmente piú eseguiti al mondo e il piú prolifico autore di teatro musicale di ispirazione post-minimalista. Ma preferiamo concludere questo breve excursus tornando ad uno dei padri fondatori, Philip Glass, che il nostro Paese ha celebrato in questo fine anno con un doppio evento: da un lato l’esecuzione in forma di concerto, per la prima volta in Italia, di Akhnaten, terzo titolo di una trilogia operistica che aveva già portato in scena le figure di Einstein (Einstein on the beach) e di Gandhi (Satyagraha); dall’altro la pubblicazione dell’autobiografia intitolata Parole senza musica.
Si tratta di un evento editoriale da segnalare non solo per l’interesse e la bellezza del testo, ma perché promosso da una grande e colta casa editrice come Il Saggiatore, grazie alla quale il minimalismo musicale si svincola una volta per tutte dal confinamento in case editrici piccole (Stampa Alternativa per Minimal, trance music e elettronica incolta di Gaetano e Tomangelo Cappelli, Textus per La musica minimalista di Paolo Coteni e Giovanni Antognozzi) o settoriali (Edt per la monografia Reich e l’autobiografia di John Adams Halleluja Junction).
Può apparire retorico, ma la storia di Philip Glass è davvero quella di un self made man americano, come ben rileva nella sua breve, ma incisiva prefazione Carlo Boccadoro, a sua volta prestigioso compositore e raffinato scrittore di cose musicali. Associandoci alle sue parole ed invitando alla lettura del volume chiunque voglia capire qualcosa di piú dell’ultimo cinquantennio di vita musicale, ci permettiamo anche di ricordare come un grande musicologo francese vivente, ma ignorato nel nostro Paese, Jacques Viret, ha scritto che «il minimalismo appare, nel seno della Nuova Musica, come la sua corrente piú innovatrice, vale a dire tradizionale».
Tradizionale? Ma Umberto Eco, sodale di Luciano Berio, non scrisse circa vent’anni fa su The New York Review of Books un pezzo intitolato «Ur-fascism», che intendeva mettere al bando ogni idea di tradizione o philosophia perennis? Ahi ahi, allora dobbiamo essere davvero in pericolo…
Antonello Colimberti
(una prima versione, ridotta, di questo saggio è comparsa su l’Unità del 1° febbraio 2016)
* Che sia esistito in passato uno stalinismo politico, pronto a stroncare, isolare e bollare chiunque si fosse opposto o sfilato dalla sua egemonia culturale, non è un mistero per nessuno: ma che ciò potesse avvenire anche in musica, e in un'attività di ricerca e di composizione che poco o nulla ha a che fare con linguaggi formali o estetici di tipo ideologico, e che anche in tal caso l'antico anatema dell'antifascismo potesse venir impiegato contro il "diverso" di turno, francamente ben pochi se lo sarebbero potuti aspettare.
-
Ringraziamo dunque Antonello Colimberti (ricercatore tutt'altro che reazionario, peraltro) per questo suo articolo interessante e puntuale, fin troppo tenero, a parer nostro, con quella casta di intellettuali "di regime" che interpretando Adorno in maniera superficiale e distorta si son sentiti in diritto, nel corso degli anni, di condannare fra gli altri anche il minimalismo musicale e il suo orizzonte culturale di riferimento, in quanto orientati in senso tradizionale e come tali da ostracizzare e da mettere al rogo.
- Fra questi - si noti - c'è pure il gran maestro della cultura pop italiana, "arbiter elegantiarum" per un'intera generazione, che prima di venire divinizzato post mortem e assunto fra gli déi dell'Olimpo ha stabilito, a suo tempo, le 14 "regole del metodo" per riconoscere il famigerato Ur-Fascism ovunque si trovi, facendo così declassare il Malleus Maleficarum o il Der Ewige Jude a manuali di serie B in materia di caccia alle streghe o di intolleranza ideologica.
Ma tutto questo ai progressisti nostrani è molto meglio non dirlo, perché l'unica cultura ammissibile è esclusivamente la loro: e chi osa metterla in dubbio, o anche semplicemente ignorarla, senza neanche saperlo si ritrova oscurato.
Il che peraltro non è poi così male, in questi tempi di magra. (PGZ)