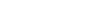1. Il silenzio di Sparta
ANCORA UNA RIFLESSIONE SULL' "ALTRA EUROPA":
CONDIVISIBILE SOLO IN PARTE, DESCRIVE UN ORIZZONTE CULTURALE
DEL TUTTO SCONOSCIUTO AL NOSTRO TEMPO
di Maurizio Blondet
Alla radice della civiltà occidentale Sparta e Atene si contrappongono come archetipi.
Atene è il dibattito, Sparta il silenzio. Atene ci ha lasciato il Partenone, l’Eretteo, i rilievi di Fidia; Sparta poche pietre mute (non aveva altre mura, come si diceva, che i petti dei suoi cittadini). Atene è l’agorà della disputa politica, Sparta è un sistema autoritario, dove ciascuno appartiene allo Stato. Atene è la libertà, Sparta la disciplina militare. Atene dà in certo senso inizio alla modernità e alla visione secolare dell’uomo, specula sugli dèi e ne dubita – mentre Sparta resta immobile in un civismo liturgico e guerriero. Atene è abitata da individui, Sparta da una falange arcaica e concorde.
Soprattutto: Atene ha prodotto una quantità e qualità prodigiosa di parole –logos, dialoghi, filosofia, sofismi, insomma ciò che noi chiamiamo «cultura», «storia», «espressione», «critica»; Sparta un silenzio enigmatico e monolitico: qualche ritmico canto di guerra, dell’antiquato Tirteo.
La vulgata democratica conferisce ovviamente ad Atene il primato della civiltà, e vede in Sparta l’assenza di spirito, sente il suo silenzio come inarticolata, brutale ottusità.
Ma se era davvero così, come spiegare che Socrate, il più vivamente loquace, il più curioso degli ateniesi, fosse filo-spartano? E che il suo discepolo più nobile ed intelligente, Platone, per cui comincia la filosofia – e comincia in forma di dialogo – guardasse a Sparta come al vero cuore spirituale ellenico?
Perché fu cosi: la fazione democratica, la «sinistra» ateniese, sospettò Socrate e Platone di lakonizein, parola pregnante che significa tutt’uno imitare i laconici nella concisione, riconoscere all’ordine spartiate un primato culturale sulla Grecia e, in senso politico, parteggiare per Sparta, essere insomma «di destra»: il che era proibito in Atene.
Certo non è semplice spiegare perché l’entourage di Socrate – il gruppo umano più culturalmente rilevante mai esistito – pur vivendo nelle libertà ateniesi, guardasse a Sparta come a un modello di prestigio impareggiabile: soprattutto perché è imbarazzante per la democrazia ammettere che la cultura «alta» nasce, in Occidente, da una visione reazionaria.
Ma la spiegazione è a portata di mano per chi non nutra pregiudizi progressisti.
Basta ricordare che Socrate parla, dialoga e disputa – e Platone scrive in forma di dialogo e disputa – non per una nativa volontà di espressione discorsiva, ma per reazione ad altri parlatori. Essi controbattono instancabilmente i sofisti: questi tecnici dell’opinione e della comunicazione, questi avvocati di ogni causa, che si vantavano di saper convincere una folla di qualunque tesi e della tesi contraria e – peggio – di poter insegnare a chiunque a fare lo stesso.
L’apparizione e il successo dei sofisti non fu visto in Atene come un «progresso», ma per quello che denunciava: il sintomo di una crisi etica che investiva la società.[1]Il trionfo del cinismo e del relativismo, della manipolazione di sentimenti collettivi in qualche modo insita nella democrazia, la negazione della verità e il primato dell’opinione. In un certo senso, coi sofisti irrompono nella storia non solo la dialettica ma la chiacchiera, la babele dei «secondo me» e il rumore di fondo della cronaca, che assedia la nostra attualità. Gorgia, il quale sostiene che «il giusto è l’utile del più forte»[2], è fin troppo moderno: pianta il germe per tutti coloro che in futuro s’inchineranno al potere di fatto come unica verità. Ha inizio un itinerario a cui Hegel darà la sistemazione teorica più concisa e universale: «tutto ciò che è reale è razionale».
Socrate il laconizzante scende dunque nella piazza, imitando i sofisti nella tecnica dialettica, per difendere un principio che è stato leso, una verità che non è più comunemente accettata in silenzio concorde. Sintomatica è la sua tecnica: più che parlare, fa domande. E le sue domande mirano a indurre gli interlocutori ad ammettere che sì, dopotutto, la giustizia non può essere ridotta alla convenienza di chi comanda, che la forza non è identica alla giustizia, che la giustizia – ancorché in questo mondo empirico non appaia se non debolmente, episodicamente – è tuttavia più reale della forza e dell’utile del più forte, tanto che l’uomo autentico con se stesso è obbligato a riconoscerle una superiorità senza compromessi. Ma com’è noto, Socrate si contenta di portare gli altri ad ammettere che la giustizia «non» è questo, non è quello, non è quell’altro; non dà mai una sua definizione del «giusto». Si rifiuta di fornire una formula, e non solo per il buon motivo che occorre difendere la Verità sottraendola alla presa della dialettica – la quale è apparsa ormai nel mondo come tecnica precipua di ritorcere gli enunciati nel loro contrario.
Nel senso più profondo, Socrate non fa che scandagliare i confini di un silenzio che contiene la verità, a cui egli attinge – e insegna ad attingere – al di là del discorso.
Come spiegare che questo silenzio olimpico da cui Socrate e Platone traggono le loro parole inesauribili è precisamente il silenzio di Sparta?
A tutta prima, piuttosto, viene a mente l’esclamazione negativa, inarticolata, con cui le Upanishad affermano l’Identità suprema – neti, neti, «non è questo, non è questo». O la cruda frase con cui Buddha (figlio di re, stirpe di kshatrya, di guerriero: uno spartiate indiano, non dimentichiamolo) tronca le dispute che le sue asserzioni dottrinali più radicali fanno sorgere tra i suoi allievi: «Non è opinione questa, nel Beato; questa è visione, nel Beato».
Il punto è questo. Anche nella Grecia di prima dei sofisti la conoscenza è chiamata invariabilmente un «vedere», rispetto al quale le conoscenze che si ottengono con tecniche discorsive, il dibattito, non sono che mutevoli e leggere opinioni: la chiacchiera sviante dei sofisti. La «visione» come conoscenza suprema era, aggiungiamo, il corrispettivo di un essere prerogativa di un tipo umano (non di chiunque) che per di più è capace di trasfigurazione.
Alludiamo qui all’iniziazione, ai «misteri» di Eleusi a cui accedevano i nobili ateniesi. In essi, testimonia Ippolito, si mostrava «a coloro che erano ammessi al grado supremo il grande e mirabile e perfettissimo mistero di visione: la spiga di grano mietuta in silenzio»[3]: e Platone si riferisce di continuo a ciò che simboleggia questa enigmatica «spiga di grano», al punto che s’è potuto sospettare che »la teoria delle idee (platoniche) fosse un tentativo di divulgazione letteraria dei misteri eleusini»[4]- e su cui l’adepto doveva mantenere il silenzio.
Ancor più, alludiamo all’oracolo di Delfi: il centro sacro ad Apollo Luminoso, così intimamente legato all’arcaica cultura dorica – di cui Sparta rimase gelosa custode, mentre gli altri mutavano – che «Licurgo»[5], per il volgo il legislatore originario, il padre dell’ordine politico spartiate, era in realtà il nome di un grado sacerdotale spartano soggetto a Delfi.
Cominciamo a capire in qual senso profondo, extra-politico, Socrate e Platone fossero filo-spartani?[6]Perché traevano le loro parole da quel silenzio che custodiva Sparta: lungi dall’essere una caserma, la città senza mura era un ordine sacro e militare i cui individui – asceticamente rinunciando a sé, prendendo il pasto comune, portando le armi come doveva aver fatto la banda originaria degli «eguali», degli etairi indoeuropei alla conquista di nuove terre – si mantenevano «originali», vicini all’origine e fedeli alla certezza che viene dalla «visione», alla cultura che è anteriore alla dialettica: quella che coltiva «la spiga mietuta in silenzio».
Che l’ordine di Sparta fosse incentrato sull’addestramento militare significa due cose: indicava che la conoscenza non si ottiene con le acutezze volatili della mente, ma lo sviluppo dell’essere, del carattere[7]; e che la verità che non può essere detta va difesa con la forza contro il caos che vuol cancellarla[8]. Anzi questo è l’unico uso legittimo della forza – la forza che impone il silenzio al rumore di fondo – e finché durò, la «visione» non fu del tutto obliata nei cuori degli uomini.
Non abbiamo evocato due archetipi perenni. Sparta e Atene sono. In ogni tempo la cultura è sofistica oppure è platonica. E se oggi dilagano la cronaca, l’attualità, il pettegolezzo, il chiacchiericcio impotente, vorremmo che le nostre parole non fossero una semplice aggiunta al rumore di fondo che cela, o intorbida, ogni certezza.
Abbiamo sempre cercato parole che diradano la nebbia in cui il caos delle opinioni ci fa vivere, che mettano in luce i duri poteri che il rumore dialettico e giornalistico ci nasconde.
Parole che non rispettano gli idoli del foro perché s’appoggiano, senza dirlo, a un silenzio forte.
Maurizio Blondet, 15 ottobre 2008
[1]La crisi, è noto, si produsse alla fine delle guerre persiane: come in ogni vittoria, emergono alla ribalta «la gente nova e i sùbiti guadagni», gli ambiziosi, gli arricchiti e i senza scrupoli.
[2]Quest’asserzione è confutata nel Teeteto.
[3]La testimonianza è di Ippolito {Confutazione, 5,8,39-40): «Gli ateniesi, nell’iniziazione di Eleusi, mostrano a coloro che sono ammessi al grado supremo il grande e mirabile e perfettissimo mistero visionario di là: la spiga di grano mietuta in silenzio».
[4]Cosi Giorgio Colli, La Sapienza Greca, I, Milano, Adelphi, 1977). Tra gli innumerevoli passi allusivi di Platone, si può citare il Fedro (248 b-c): «Tutte le anime poi, con questo tormento, se ne vanno senza essere state iniziate alla visione di ciò che è, e allontanatesi si nutrono con il cibo dell’opinione».
[5]Licurgo è nome connesso a «Liceo», l’appellativo di Apollo che allude alla Luce (ciò che dà la Visione) e al Lupo, il totem dell’arcaica religione iperborea, della «luce del Nord».
[6]Ma anche Aristotele stabilisce una gerarchia «tra ciò che appartiene all’insegnamento e ciò che appartiene all’iniziazione. Il primo giunge agli uomini attraverso l’udito, la seconda invece quando la capacità intuitiva stessa subisce la folgorazione, il che appunto fu chiamato anche misterico, e simile alle iniziazioni di Eleusi». (Sulla Filosofia, fr.15).
[7]Che la conoscenza autentica non sia per tutti, ma per una natura umana qualificata, è detto nel Simposio platonico (209e): «A queste dottrine d’amore, orbene, anche tu forse, Socrate, potrai essere iniziato; ma al grado perfetto e visionario dei misteri d’amore (…) non so se tu sarai capace di esserlo». Confronta anche Aristotele: «Gli iniziati non debbono imparare qualcosa, bensì essere recettivi (pathéin) ed essere in un certo stato, evidentemente dopo essere divenuti capaci di ciò».
[8]Vi sono pensieri che non è consentito a tutti nutrire, e licenze che non possono esser concesse, anche se la facoltà di imporre il divieto spetta ad uomini forti, cioè disposti a morire. La mentalità contemporanea che fa della trasgressione un diritto è, prima che allarmante, indecente e ridicola: anche la trasgressione è solo per chi sa assumersene le estreme conseguenze: anch’essa è una iniziazione sui generis, e richiede una stoffa, un «carattere». (...)

-
2. Caste e razze
RIFLESSIONI "NON CONFORMI" SULL'ANTIEGUALITARISMO ESOTERICO*
Commento a Frithjof Schuon, Caste e razze,
Edizioni all’insegna del Veltro, Parma, 1979
di Michele Fabbri
L’ideologia dell’antirazzismo è il vero e proprio oppio dei popoli: questa potente droga viene furbescamente utilizzata dalla classe dirigente “democratica” per distrarre l’opinione pubblica dai problemi più pressanti e per far ingollare alla società civile il nuovo ordine mondiale che si concretizza in una surreale società “multirazziale” che nei fatti assume inevitabilmente i caratteri di una società multirazzista e multicriminale. “Lotta alle discriminazioni” è un’espressione che ha un effetto lisergico sulla personalità debole, frammentata e facilmente impressionabile dell’uomo contemporaneo, ormai regredito allo stadio infantile e disposto a credere alle favole più inverosimili.
Il mondo della Tradizione era invece fondato su un sentimento forte delle identità di razza, di casta e di religione: per capire questi aspetti di storia della mentalità è utilissimo il libro di Frithjof Schuon Caste e razze, che l’autore pubblicò in francese nel 1957. Schuon fu uno dei più qualificati studiosi di storia delle religioni, che egli interpretava alla luce della philosophia perennis, mettendo in luce le analogie fra culture distanti nel tempo e nello spazio. Caste e razze è un testo di grande attualità, che ha anticipato di decenni le concezioni differenzialiste oggi diffuse nel dibattito culturale.
*
La trattazione di Schuon si apre con la definizione dell’istituto delle caste, che trova la sua giustificazione nella differenziazione dei tipi umani con la conseguente diversità di attitudini e di qualificazioni. Nell’Induismo il sistema delle caste ha conosciuto la sua applicazione più rigida basata sul principio di ereditarietà della casta, mentre nell’Ebraismo e nell’Islam le caste sono assenti, poiché in queste culture ha prevalso la considerazione ugualitaria secondo la quale tutti gli uomini sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Fra queste due concezioni c’è l’Europa cristiana medievale, nella quale la società era divisa in caste ma in modo abbastanza flessibile: la casta sacerdotale era vocazionale e la casta guerriera poteva accogliere elementi delle caste dei lavoratori attraverso processi di nobilitazione, e in questo modo poteva verificarsi l’eventualità che un contadino diventasse papa e consacrasse l’imperatore. Ma gli appartenenti alle caste, anche alle più umili, avevano ciascuno una propria dignità e delle qualità specifiche che ne determinavano la funzione sociale. Le antiche società gerarchizzate creavano anche spazi per individui senza attitudini particolari, dalla psicologia caotica e poco definita e quindi portati alla trasgressione: per proteggere l’ordine sociale dalla contaminazione di questi elementi si formavano i gruppi dei “fuori casta” e degli “intoccabili” nel mondo induista, oppure degli ebrei e degli zingari nel mondo occidentale.
La mentalità moderna, fondata su concezioni ugualitarie derivate da grossolane e improbabili ideologie materialiste, e particolarmente avversa al principio di ereditarietà, ritiene inaccettabile dividere l’umanità in caste. Ma le caste antiche, come si è visto, avevano una funzione sociale che equilibrava le attitudini umane, mentre il materialismo moderno ha trasformato gli elementi mediocri in classe dirigente e di fatto ha ribaltato il senso delle caste, assegnando a incapaci e parassiti prerogative e privilegi del tutto ingiustificati, e determinando le disfunzioni sociali che caratterizzano il mondo contemporaneo. Nell’antichità e nel medioevo gli uomini avevano una chiara coscienza del senso del limite ed erano consapevoli dei rischi che l’umanità correva se lasciava spazio alle forze demoniache che si collocavano al di fuori dell’orizzonte del sacro. Nel mondo moderno, invece, la meccanizzazione e la tecnologizzazione dell’economia hanno creato la massa dei “proletari”, che non corrisponde a una casta naturale ma a una collettività quantitativa.
Per rendere conto delle assurdità di cui è responsabile, la cultura moderna è riuscita perfino a dare una sovrastruttura pseudoreligiosa alle sue concezioni “umanitarie”. L’umanitarismo, infatti, ritiene che la totalità degli esseri umani sia il Dio personale: una concezione che degrada il divino al livello umano, mentre nella concezione tradizionale è l’umano che si sforza di elevarsi verso il divino. Da questa idea del sacro deriva una carità equivoca che salva i corpi ma uccide le anime; i difetti delle persone sono attribuiti a condizioni materiali sfavorevoli, quindi le coscienze vengono deresponsabilizzate, poiché i comportamenti devianti e criminali sono accettati e incoraggiati sulla base delle spiegazioni “sociologiche” che tanto successo riscuotono nella cultura contemporanea. Il terzomondismo, poi, è riuscito a elaborare concetti a dir poco fuorvianti sull’idea di “benessere”. La nozione di “paese sottosviluppato”, nella sua candida perfidia, è ispirata a una concezione rozzamente materialista della vita: per i progressisti la felicità consiste in uno sviluppo tecnologico destinato a distruggere molti elementi di bellezza, e dunque di benessere, mentre ci si dimentica che esistono atrocità sul piano spirituale, e di queste atrocità è satura la cultura umanitarista dei moderni. In nome dell’umanitarismo le vocazioni vengono calpestate e le persone di genio vengono umiliate in una scuola il cui scopo non è più quello di selezionare i migliori, ma quello di omologare le intelligenze nella mediocrità imperante.
Schuon fa notare che il livellamento moderno e democratico è agli antipodi dell’ugualitarismo religioso: l’uguaglianza delle religioni monoteiste, infatti, si fonda sul teomorfismo dell’uomo, mentre l’uguaglianza democratica prende a modello l’animalità. Nella concezione religiosa della vita, gli uomini sono tenuti a vedere nel prossimo l’immagine di Dio e a trattarsi come dei santi “virtuali”: in questo senso anche i più umili assumono un contegno aristocratico. La modernità, invece, elevando il progresso a ideologia, ha preso la ricchezza a metro di giudizio di tutte le cose, considerando la povertà come una sorta di maledizione e creando odiose forme di esclusione sociale assai più rigide di quelle messe in atto dal sistema delle caste. In modo analogo le ideologie moderne hanno preteso di annullare le differenze fra uomo e donna, distruggendo la famiglia naturale e creando lo scenario di disgregazione sociale che la modernità ci ha messo sotto gli occhi.
*
Passando a trattare il tema delle razze, Schuon mette subito in chiaro che la casta prevale sulla razza, poiché la razza è una forma, mentre la casta è uno spirito, e lo spirito prevale sulla forma. Sarebbe però assurdo pensare che le differenze razziali non implichino diversità di attitudini e di atteggiamenti: se è giusto respingere sentimenti di odio ispirati a motivi razziali, è altrettanto giusto respingere un antirazzismo pregiudiziale che pretende di uniformare tutte le diversità, con l’evidente scopo di offrire al potere dei tecnocrati mondialisti una massa di cittadini-schiavi incapaci di pensiero critico.
Schuon analizza i tre principali gruppi razziali in cui si divide l’umanità, Bianchi, Neri, Gialli, che egli assimila agli elementi naturali: il Bianco al cielo, il Nero alla terra, il Giallo all’acqua. Ognuna di queste razze ha dato vita a organizzazioni sociali ispirate alle rispettive caratteristiche, e all’interno di questi grandi gruppi ci sono ulteriori differenziazioni, dovute a fattori culturali e storici che hanno segnato le varie civiltà. In particolare, all’interno della cultura bianca ci sono sempre stati momenti di confronto, e talvolta di conflitto, fra culture nordiche e culture mediterranee, nonché fra mentalità pagana e mentalità cristiana, fra messianismo monoteista e avatarismo ariano.
Schuon, inoltre, rimarca l’importante distinzione fra popoli e stati: infatti il popolo non sempre coincide con lo stato, anzi nel mondo moderno sempre più spesso diversi popoli vivono all’interno dello stesso territorio, e proprio per questo oggi è tanto più importante che i gruppi etnici acquisiscano una chiara coscienza della loro identità. Le mescolanze razziali, infatti, se da una parte possono arieggiare un ambiente troppo chiuso, d’altra parte rischiano di far scomparire gruppi umani dalle qualità preziose: il modello della società multirazziale, oltre a essere un palese fallimento sul piano della coesione sociale, rappresenta infatti un impoverimento delle culture umane, che dovrebbero arricchirsi nel confronto fra le differenze, anziché annullarsi reciprocamente nell’omologazione globale. A questo proposito, Schuon conclude il libro con una considerazione che sintetizza efficacemente il senso della questione razziale al di là di ogni forzatura ideologica: «le qualità che rendono amabile un certo essere umano, rendono nello stesso tempo amabile il genio della sua razza…l’uomo di un’altra razza è come un aspetto dimenticato di noi stessi, e dunque uno specchio ritrovato di Dio».
Michele Fabbri, commento a
Frithjof Schuon, Caste e razze, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma, 1979
http://www.centrostudilaruna.it/caste-e-razze.html
* Una tematica quantomai attuale, in questo tempo di confusione di massa e di luoghi comuni d'élite. Senza cadere anche noi nell'errore, molto diffuso nel nostro tempo, di identificare "tradizione" con "tradizionalismo" e "reazione", cerchiamo di accostarci senza pregiudizi alla lettura di questo articolo, che ha il pregio di presentare il punto di vista tradizionale sull'argomento, sfatando in tal modo la vulgata modernista a riguardo.
Ho letto il libro di Schuon già molti anni fa e l'ho trovato illuminante e istruttivo, e - pur non condividendolo in toto - ne consiglio la lettura a quanti vogliano accostarsi senza pregiudizi agli insegnamenti immortali della 'philosophia perennis'. (PGZ)